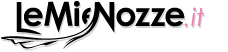Cerimonia

Il monumento più importante che ha fato conoscere Brunello è la chiesa di Santa Maria Annunciata.
E’ una piccola basilica sorta solitaria, lontana dal centro abitato, congiunta ad un piccolo convento.
La sua facciata è a capanna. Il portale mediano è originario. Le due finestre ai lati e quella sopra il portale sono più recenti. Il rosone primitivo, rotondo, è stato alterato quando s’aggiunse il soffitto orizzontale che nascose le antiche capriate.
C’era anche un secondo ingresso laterale, a sinistra, ora murato e rilevabile dall’interno. Metteva in comunicazione, tramite una scala esterna, ora soppressa, gli alloggi del convento con l’aula ecclesiale.
L’interno è ad aula unica, in stile lombardo-gotico come risultata dall’arco trionfale del presbiterio e dal presbiterio stesso.
Chiesa e convento pare siano appartenuti all’ordine degli Umiliati. […]
Una seria valutazione storica ne stabilirebbe la fondazione tra la fine del 1200 e gli inizi del 1300, 150 anni circa anteriore agli affreschi, uno dei quali pare datato 1470. […]
Questa chiesa non poteva che sorgere là e non altrove.
Hanno concorso alla scelta del posto la posizione, l’esposizione panoramica, il pianoro idoneo ed anche il confine giurisdizionale, in quel punto situato, del Seprio Superiore facente parte a Varese.
S’aggiunga, elemento importantissimo e decisivo, la comodità d’accesso.
Infatti di lì passava la vecchia e importante strada medioevale, detta Varesina che partendo da Varese attraversava Erbamolle (S. Caterina), percorreva la gola tra il colle del S. Quirico di Azzate e il Colle del Montuccio di Brunello ed inerpicandosi sul versante della Valle Sole, giungeva alla chiesa.
Da qui volgeva ad ovest verso Crosio (Sant’Apollinare) e Montonate (S.Alessandro) con diramazione per Caidate (S. Genesio) entrando nel territorio del Seprio Inferiore.
Per qualche breve tratto è ancora possibile trovare il vecchio acciottolato.
E’ la strada percorsa da S. Carlo nella sua visita pastorale del 1574, il quale potè dissetarsi ad una fresca sorgente, detta da allora “ul funtanin da S. Carlu”. […]
Tanto più, è leggenda, che il Santo, assetato e stanco, salendo, desiderava un sorso d’acqua fresca.
Ecco, il cavallo suo con un poderoso colpo di zoccolo smosse la terra e ne sgorgò un rivolo limpido che dura tuttora.
|
Certo la comunità antica e minuscola di Brunello non deve aver avuto né esigenza né interesse né possibilità nella faccenda.
Per i suoi bisogni religiosi bastava la “Chiesuola” tra le sue case l’assistenza saltuaria di sacerdoti esterni. Che si sia poi appoggiata poi per le sue devozioni alla nuova chiesa che, un giorno abbiamo proposto, venisse aggiuntivamente chiamata “Sancta Maria in vineis” (“la Madonna nelle vigne”) è vicenda e soluzione naturale. |
 |
Si deve pensare a un ente religioso di buona possibilità che non ebbe esitazione a farla così straordinariamente adorna.
Anche per questo motivo vien da pensare: gli Umiliati. […]
Attraverso l’arco, detto un tempo popolarmente portone di Sant’Orsola, che è propriamente della Madonna di Misericordia, dal grande affresco della Vergine, dolcissima, protettiva, col suo manto, del popolo cristiano, si entra nel Sagrato che era cimitero che si usava anticamente.
In una piantina del secolo XVI è detto esplicitamente “porta del cimitero”.
Purtroppo l’affresco è così mal ridotto che della Madonna rimane il dolce viso ma il popolo cristiano è scomparso.
Questa gentile Madonna possiamo ben chiamarla “del cortese incontro o della buona accoglienza”.
Se vogliamo leggere la scrittura che fa da cornice al dipinto ci sentiamo confortati.
Essa dice: “...(Venite a me omnes, qui laboratis et onerati…) estis et ego reficiam vos. Jugum meum enim suave est et onus meum leve est” (Mt. 11,28.30) “… (Venite a me tutti che stanchi ed aggravate…) siete ed io vi darò riposo. Il mio giogo difatti è agevole ed il mio carico è leggero”.
Sul cartiglio dell’angelo visibile è scritto :; “Sicut lilium inter spinas, sic amica mea inter (filias)” “Come un anemone tra le spine così la mia amata tra (le fanciulle)”. (Ct. 2,2)
Appena in Chiesa, la visione del gran giudizio universale è meravigliosa. E’ forse l’unico giudizio universale in Lombardia.
Il Cristo giudice nella mandorla formata da una ghirlanda di angeli fa suonare le trombe del giudizio, premia i buoni alla sua destra e punisce i cattivi alla sua sinistra.
I giusti, accolti dagli angeli alla porta del cielo (porta caeli) vanno verso il Paradiso; i reprobi, ignudi per il peccato, son cacciati nelle fauci d’un drago infernale.
L’autore è ignoto. Si usa chiamarlo “Maestro di Brunello”.
E’ un pittore, lui e i suoi aiutanti, che, nel gran scenario del giudizio universale, hanno eternato la stupefacente atmosfera di questo nostro incantevole colle, anche se il paesaggio, consentaneo all’oltretomba, è meno verdeggiante.
Questo dipinto principale si presenta di non comune finezza ed abilità.
Sorprende la concezione grandiosa, lo stile libero, naturale e particolare, tipico d’un artista lombardo della fine del 1400 e del principio del 1500. […]
Se il grande affresco attira subito e giustamente l’attenzione, vanno poi osservate altre pregevolissime pitture, per alcune delle quali è pensabile l’apporto anche di alcuni artisti locali (Pietro da Velate).
Nell’absidiola sinistra: la Madonna col Bambino e Santa Caterina d’Alessandria.
Nell’absidiola destra: la Madonna col Bambino e San Rocco e San Sebastiano.
Sulla lesena sinistra: Santo Stefano.
Sulla lesena destra: San Miro o San Lucio.
Sulla parete sinistra: un seguito di dipinti votivi (una figura parziale di Santo (S.Bernardino da Siena), la Vergine in trono con bambino, un santo benedicente , la Vergine che adora il Bambino, un santo monaco, la Vergine in trono con il Bambino e S.Caterina, una santa monaca che reca la pisside (S.Chiara) ed ancora la Madonna con il Bambino (particolarmente dolce nel decoro e nel ritmo).
Nelle vele del presbiterio: i quattro dottori magni d’occidente ed i quattro evangelisti, appaiati.
Sulle due pareti del presbiterio: sei apostoli ed un’Annunciazione.
Nella cappella, a destra, la Vergine Alma Madre.
Il soffitto è finemente dipinto nelle sue formelle quadrate. Le pareti poi avvolgono l’aula con singolare motivo graffito. […]
Gli affreschi furono scoperti più di cinquanta anni fa sotto un imbianchimento che li aveva nascosti. Chi li aveva fatti scomparire?
Forse Gaspari Bossi, primo parroco del 1565, per ragioni moralistiche dettate dal costume severo della Controriforma?
Forse lo stesso parroco per cancellare, dove almeno era possibile, l’opera degli Umiliati, per i quali non tirava aria propizia e proprio allora soppressi?
O a seguito della peste del 1576, la peste di San Carlo, quando appunto il grande arcivescovo consigliava di dar mani di calce alle pareti per disinfezione?
Certamente ci fu la peste a Brunello e ne rimane il ricordo nel nome del sito dove esiste l’attuale cimitero, detto appunto “Lazzaretto”. La chiesa del Lazzaretto, legata al comitero, è significativamente dedicata a S. Carlo.
Per provvidenziale ventura, la chiesa, passata in proprietà della Diocesi di Milano, fu eretta in parrocchia secondo gli intendimenti del Concilio di Trento ed affidata a chi n’ebbe subito interesse e non abbandonata alla decadenza come accade per altre residenze di quell’ordine monastico.
Sicuramente non ne sapevano nulla degli affreschi i due parroci Giovanni ed Andrea Contini, zio e nipote che dal luglio 1799 al febbraio 1878 ressero la parrocchia. E non fu male perché, se è vero quanto dicevano gli anziani, l’Andrea commise la tristissima azione di vendere la pala centrale del “Polittico”, dipinto sul legno, nonostante la contraria volontà dei maggiorenti, rovinando irreparabilmente un’opera di gran valore.
Neanche don Luigi Fontana che successe nel 1879 e morì nel 1904, né la sua sorella, ottima pittrice, furono al corrente.
Questi tre parroci furono gli unici sepolti nel cimitero con i loro fedeli, che il Fontana definisce “buoni Brunellesi”.
Se non si sa chi coprì i celebri affreschi, è ancora vivo chi ebbe la ventura di vederli finalmente con occhi rivelatori e ne conserva segreti nell’animo l’orgoglio e la commozione da allora.
Qualcuno si sarà accorto chepiù su si da differente denominazione alla figura che sta sulla lesena destra dell’arco trionfale in contrapposto a Santo Stefano chè è a sinistra.
Autori rispettabilissimi asseriscono che è San Rocco che soccorre una donna. Qui si dice che è San Miro.
Così almeno indicò un dotto di straordinaria sapienza e competenza: il cardinale Schuster.
Egli, durante una visita pastorale, si avvicinò alla figura, l’osservò con attenzione, rivolse la sua mente ad una a lui nota tradizione iconografica ed esclamò, senza esitazione: “Un santo che porta la pentolina del latte non può essere che S. Miro”.
Prima di passare ad altro argomento convien notare che la chiesa ha subito notevoli mutamenti dall’inizio del 1600.
Una pianta dell’edificio di quel tempo, che presenta la struttura originale, ci fa rilevare che la sacristia non è a destra, come ora, ma a sinistra; la cappella della Madonna a destra non c’era; l’abside non esisteva, nuove finestre sono intervenute in seguito.
Tutto il lato di mezzogiorno era un porticato, interrotto da una cappellina. Abolito il porticato e chiuso, risultarono la sacrestia attuale, un locale per gli arredi, la cappella della Madonna ed il Museo.
Il conventino a settentrione, addossato alla chiesa, divenne la casa del parroco.
E’ stato rilevato che l’abside è un poco deviata rispetto all’asse mediano della chiesa e si sostiene che s’è voluto per l’appunto simboleggiare l’inclinazione del capo di Cristo sulla croce.
L’interpretazione è forse un tantino sofisticata. Basterebbe, per giustificare l’anomalia, pensare a necessità costruttive specifiche in quella porzione di terreno. Perchè all’epoca della nuova costruzione non si ricorreva più tanto facilmente alla simbologia. Ad ogni modo la notizia è riferita per rispetto delle altrui opinioni che possono anche essere più rispondenti a verità.